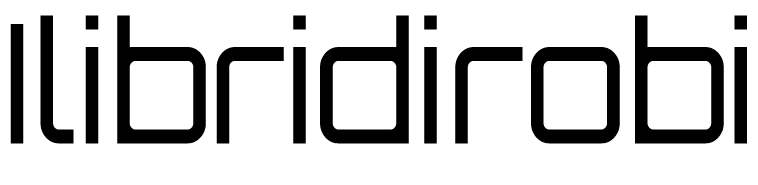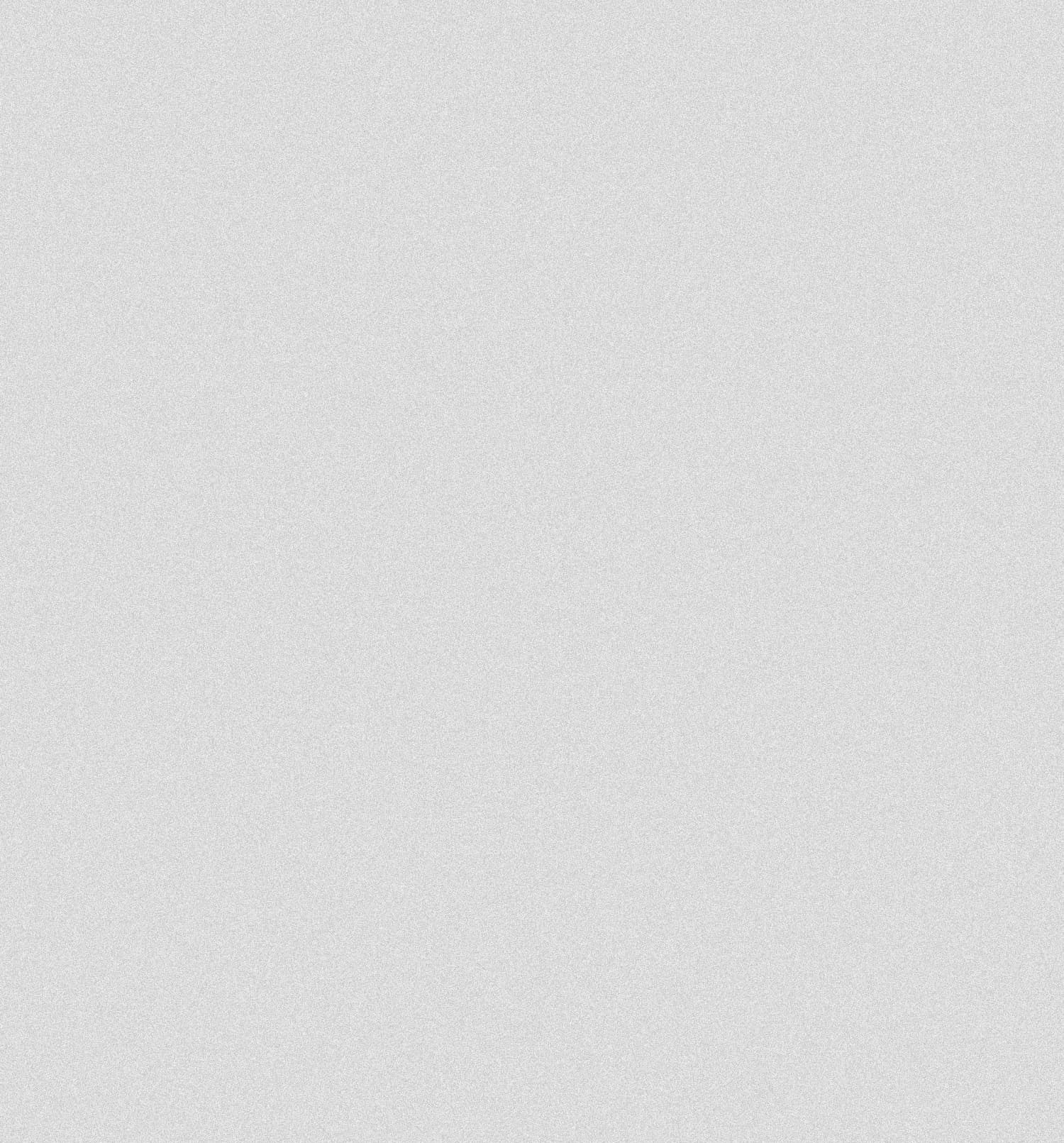Stella Maris
L’inconscio evolve di pari passo con la specie per rispondere ai suoi bisogni e se ha qualcosa di inquietante è che a volte quei bisogni li anticipa.
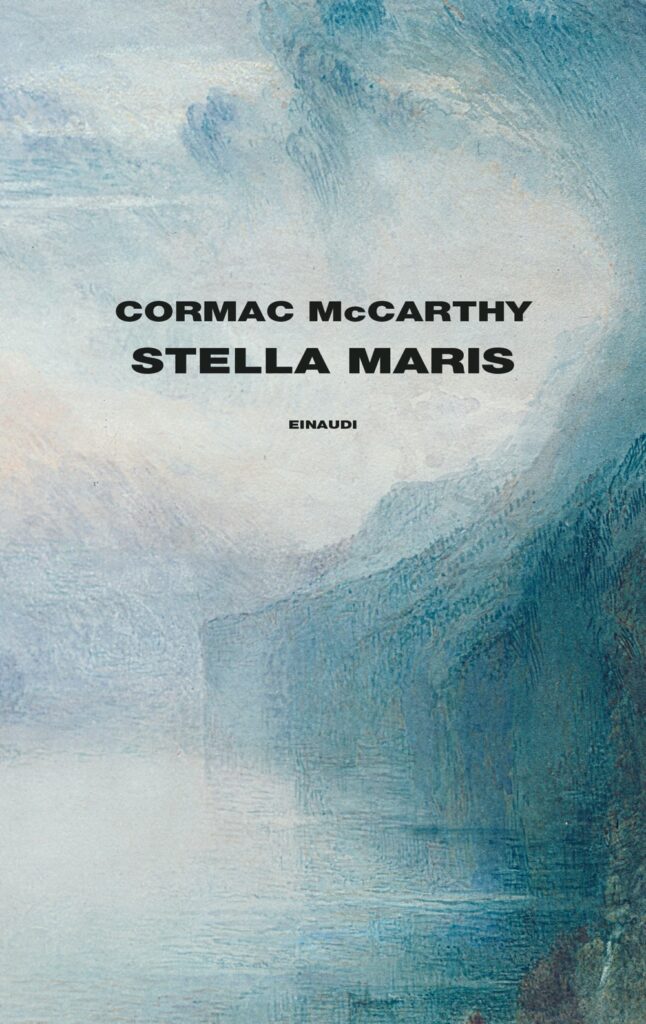
Stella Maris è una profonda e delicata storia d’amore ed è un viaggio nelle leggi che regolano il mondo, in quelle che guidano l’essere umano e nell’inconscio.
A condurre questo viaggio è Alicia Western, una ventenne prodigio dottoranda in matematica, con differenti disturbi psichici e della personalità, che si reca volontariamente a Stella Maris, casa di cura per pazienti psichiatrici, dove è già stata ricoverata in passato.
E’ l’ottobre del 1972; ad accoglierla c’è il dottor Cohen e, tra i due, inizia un discorso fitto che si perde e si ritrova ad ogni incontro.
L’intento dello psichiatra è far emergere le sue fragilità e farle sciogliere i suoi nodi parlando del suo vissuto complesso e del suo dolore per la perdita del fratello cercando di farla riemergere da questo stato di anestesia emotiva in cui si trova.
Alicia è la sua matematica: l’unica entità sociale di cui lei abbia mai fatto parte; è la sua musica paradossalmente misteriosa ed inspiegabile, magica, irraggiungibile; è l’emozione e il rispetto per il suo violino;
Le note stesse non corrispondono praticamente a niente. Ma come mai una disposizione particolare di queste note possa influenzare così profondamente le nostre emozioni resta un mistero che va addirittura oltre ogni speranza di comprensione. La musica non è un linguaggio. Non allude a niente se non a sé stessa.
è l’audacia e l’impertinenza con cui sbeffeggia Jung e la sua psicologia; è l’avversione per il linguaggio che definiscine un parassita ostacolatore dell’inconscio, il quale sa perfettamente cavarsela autonomamente, come dimostrato nel sogno di Kekulè ;
Si. La guida interiore di un sistema vivente è necessaria alla sua sopravvivenza quanto l’ossigeno e l’idrogeno. La gestione di qualunque sistema evolve di pari passo col sistema stesso.
è la sua amicizia immaginaria con Thalidomide Kid; è la delusione per la sua famiglia cruda ed emotivamente analfabeta; è la sua solitudine e alienazione che la portano in questa clinica, alla ricerca di quelle cure e affetto mancato, fino ad arrivare ad identificarla come la sua unica casa; è la sua ironia, furba e consapevole, che mette in tavola con il suo interlocutore, per fuggire dalla sua stessa profondità, finendo per confonderlo.
L’unico passeggero degno di affiancarla in questo viaggio è suo fratello Bobby, verso cui nutre l’amore assoluto e straziante e di cui non vuole parlare, perché “gli affari di cuore hanno diritto ad una certa riservatezza”.
Non voleva farlo preoccupare.
Non volevo farlo preoccupare.
Sopporta male la gente che vuole aiutarla.
Sopporto male la gente che vuole aggiustarmi.
Cormac McCarthy scrive un dialogo raffinato, contorto, geniale, colto, intimo, doloroso e arguto, che ipnotizza ed apre le porte a spunti di riflessione unici.
Riesce a far appassionare ad un libro composto solo da dialoghi, che tratta argomenti differenti e complessi, espressi sotto forma di discorso confidenziale, senza nemmeno fornire una distinzione netta delle singole parti, disegnando un personaggio affascinante e con una personalità fortissima, piena di sapienza e intuito, che rivela un’anima sensibile e straziata dal dolore.
Senta. Non serve a niente che mi ripeta queste cose come per tratteggiare l’orrore e la follia. Lei non può vedere il mondo che vedo io. Non può vedere con questi occhi. Non potrà mai.
Di questo sono sicuro.
La sua scrittura comunica un potente senso di smarrimento, mescolato alla totale rassegnazione, entrambi figli della perdita dell’amore; il tutto accompagnato da una profonda tenerezza che, come il vibrato di un violino, oscilla nell’intero libro.
In tutto il romanzo c’è una continua connessione tra la scienza e le relazioni umane: tra le due parti, a vincere è sempre la scienza, come se una cosa debba per forza escludere l’altra, anzi l’amore per le proprie ambizioni si contrappone all’amore per l’altro e verso l’altro, un amore che viene raccontato come dettaglio e non come uno dei fulcri dell’esistenza stessa. Tuttavia, il paradosso sta proprio nella totale depressione e perdita di vita, che la protagonista subisce dopo la morte celebrale del fratello.
McCarthy analizza al microscopio la creazione della bomba atomica, ponendo l’obiettivo ancora una volta sulla dualità dell’essere umano. Da un lato c’è il fascino della scoperta scientifica che nobilita l’uomo, il suo ego le sue capacità e ambizioni e, dall’altra parte, zoomma sulla responsabilità etica dello scienziato e soprattutto sulla responsabilità morale che risiede nella coscienza umana, che esiste proprio come organo autonomo, imponendo sempre un limite che, come una scimmietta dispettosa, si palesa sempre, pur essendo a discrezione personale scegliere se e quando vederla.
E mio padre che guardava attraverso le dita come Mizaru. Ma se anche non sapevano altro sapevano tutti che per non vedere il male era troppo tardi.
Con Stella Maris, Cormac McCarthy, mette in scena un numero di magia perfettamente riuscito: attraverso teoremi matematici di Grothendieck e Gödel, la meccanica quantistica di Feynman, la fisica nucleare di Oppenheimer, concezioni filosofiche e teorie evoluzionistiche, mostra la profondità cosmica, paragonandola alla profondità e complessità emotiva dell’essere umano e fa emergere solo la giustizia del riuscire ad essere umanamente se stessi e l’assoluta necessità di essere amati e riconosciuti come amabili.